AltrodiBlogger Erranti,23 Novembre 2011
David Lynch – Crazy Clown Time: la recensione
Bizzarra vacuità. Si prova un po’ di amarezza nel liquidare così questo Crazy Clown Time, primo album, pensato al di fuori dell’ambito cinematografico, a portare la firma di David Lynch nella sua interezza.
Quattordici pezzi registrati in studio col fidato ‘Big’ Dean Hurley, quattordici tasselli che si possono far rientrare comodamente nella gamma di modalità espressive e di atmosfere del Lynch regista e del Lynch compositore di soundtracks: dai blues cadenzati che evocano scenari torbidi e incerti all’effetto straniante e disumanizzante dei pezzi più elettronici. Un vocabolario che applicato a film capolavoro come Eraserhead, Blue Velvet, Strade perdute e Inland Empire ha saputo esprimere come niente prima, le inquietudini, le ambiguità, le perversioni che permeano la realtà urbana post-industriale e i rapporti tra chi, in essa, si muove in modo più o meno cosciente, più o meno volontario.
E allora cosa non va? Cosa cambia? Innanzi tutto la componente musicale, o almeno questa componente musicale, così connotata, se privata del contrappunto visivo perde buona parte della sua forza evocativa. La scontatezza, la ripetitività, la disarmante elementarità di un motivo può essere elemento efficacissimo per potenziare determinati effetti ipnotici, di spaesamento, di destabilizzazione. Quando lo stesso motivo diventa una traccia di 5 minuti su album l’effetto è soltanto imbarazzo e noia. Penso a The Night Bell With Lightning ma la descrizione si adatta facilmente alla maggior parte dei brani.
La seconda ragione di un flop l’ho inavvertitamente anticipata. “Quando lo stesso motivo diventa…”: sì, lo stesso motivo. Gli stessi motivi. Non c’è un solo spunto nuovo, un pezzo imprevisto, una suggestione inaspettata. Tutto è già stato sentito in precedenza e meglio. L’interminabile Strange and unproductive thinking, che tra l’altro pare una dichiarazione d’intenti, offre sette minuti di sproloquio robotico condito di nulla, She rise up, cinque minuti di sproloquio robotico, ma con effetto rallenty. Mi sembra azzardato parlare di interessante ricerca musicale e sottile sperimentazione (come si è ahimè fatto).
Non disprezzabile il pezzo di apertura Pinky’s dream, con la voce di Karen O degli Yeah Yeah Yeahs, che può anche far ben sperare ma giusto per un attimo. Poi resta solo quel sapore amaro di bizzarra vacuità. E di una strada perduta inseguendo feticci consumati dal tempo e dalle mode.
Scritto da Barbara Nazzari.
![]()
Continua a errare con noi su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito








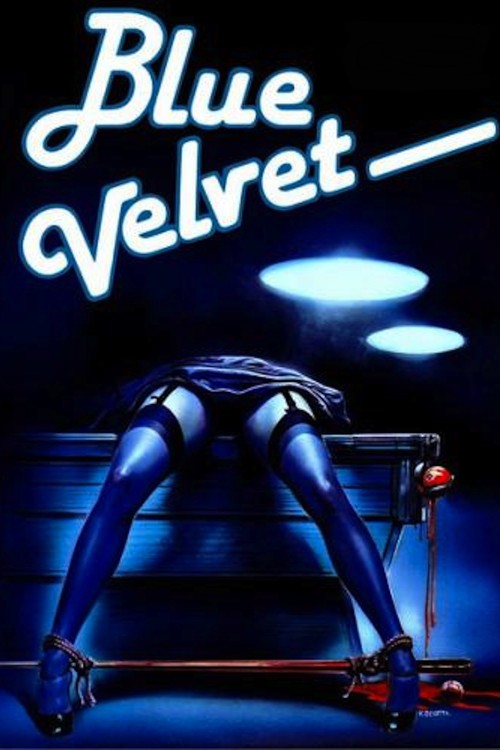
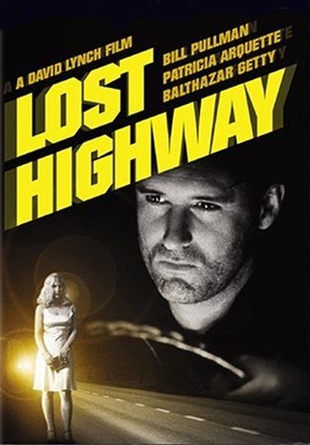







































































































Riconosco le dinamiche che dici e non ne nego il fascino. Dal mio punto di vista però sono ormai un po’ troppo inflazionate (e di conseguenza impoverite di significato) per pensare possano bastare a se stesse. Dopo trentacinque anni di notevole percorso artistico mi sembra una scelta non proprio coraggiosa nè particolarmente stimolante
Non sono d’accordo. Lo ritengo al contrario un album pienamente riuscito, che si muove incessantemente tra i due poli del caldo e del freddo (il battito sotterraneo della metropoli e quegli scenari sintetici così astratti). E’ una musica in cui la ripetezione non solo acquista un senso, ma diventa persino elemento portante: l’ossessione non può darsi senza ripetizione.