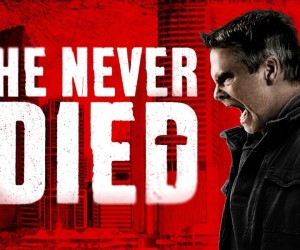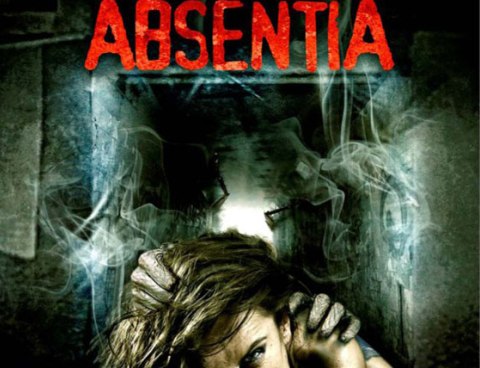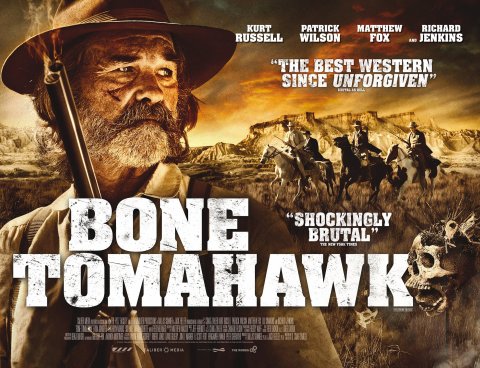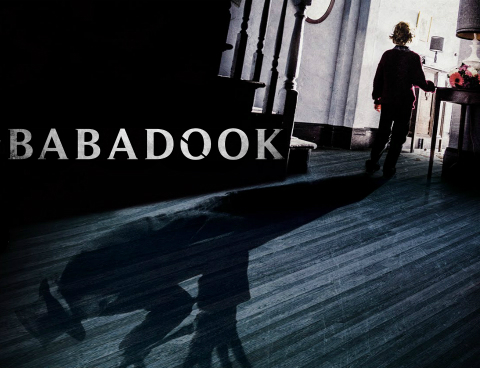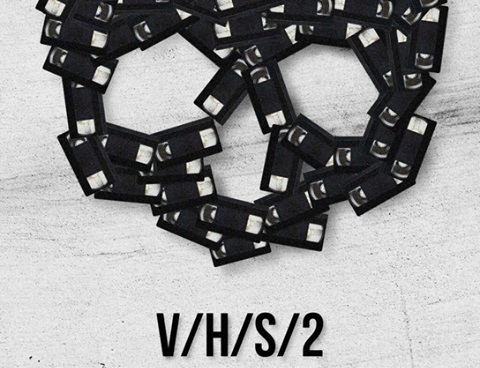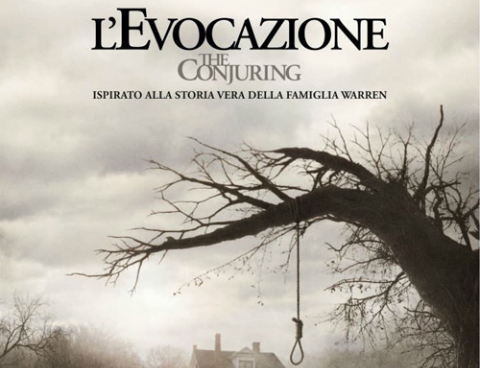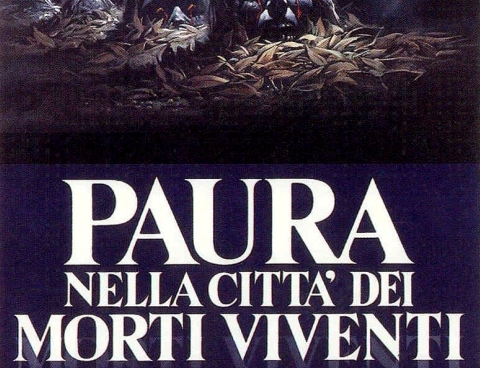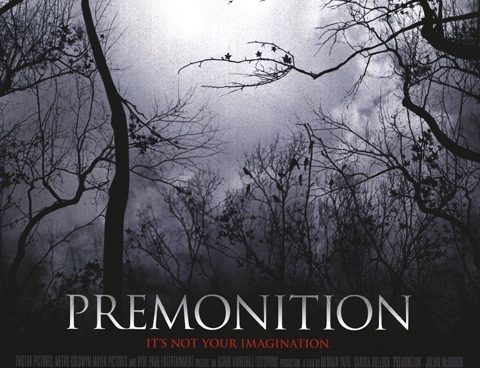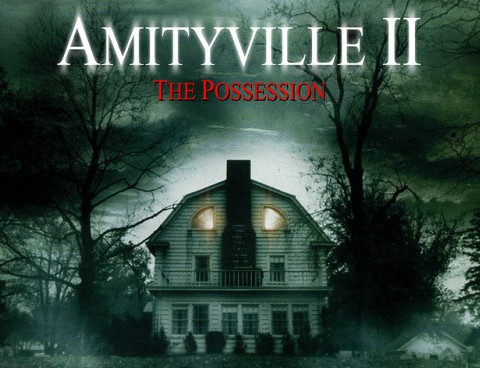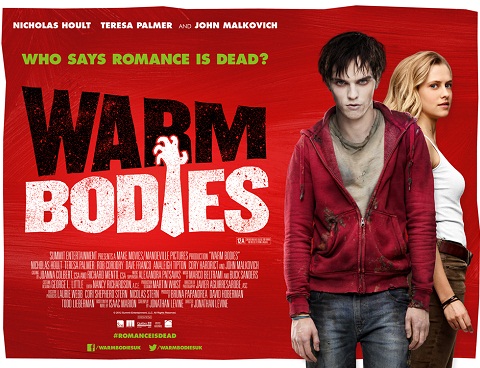Horror Ketchup – La vergine di Norimberga: la recensione
Un horror di Margheriti con aria stantia di castello e soffi visionari
Con l’attacco jazzistico delle musiche di Riz Ortolani, presto disciolto nel rallentamento del contrabbasso che fa da letto a una suadente e affabulante melodia, si apre La vergine di Norimberga di Antonio Margheriti, accreditato come Anthony Dawson perché l’anglofonia funzionasse da salvacondotto artistico. Pregiudizi a parte, non ce ne sarebbe (stato) bisogno, considerando le eccellenti prove del nostro regista nel campo del cinema di genere. Oltre ai pioneristici esperimenti di fantascienza a budget minimale (si pensi alla cosiddetta quadrilogia Gamma Uno, due anni fa riproposta in home video dalla Medusa), più di una perla nera si può annoverare nella produzione di Margheriti. Nello stesso anno di Danza Macabra, il regista licenzia anche La vergine di Norimberga, che oggi potrebbe apparire come circonfuso d’una inattuale pompa ottocentesca, intriso com’è di atmosfere gotiche: eppure, proprio queste ambientazioni e questi umori sono valorizzati nella veste visiva, con un inatteso twist finale pienamente calato nell’incubo novecentesco, nell’accennare con spettacolare, calcolato sadismo a storie di macellai nazisti.
In un castello di proprietà del marito, Mary Hunter (Rossana Podestà) si sveglia di notte, segue un lamento e finisce in una sala delle torture, dove vede il corpo di una donna nel congegno sadico noto come “la vergine di Norimberga”. Persi i sensi, rinviene il giorno dopo tra le rassicurazioni del marito, Max (George Rivière), che le dice trattarsi di un incubo e le spiega che la sala è un museo di un sinistro antenato. Persino il minaccioso, sfregiato custode, Erich (Christopher Lee), sarebbe innocuo. Ciò non impedisce a un crudele assassino, di rosso vestito proprio come l’avo, di aggirarsi davvero per il castello. Indaga addirittura l’FBI, ma ci vorrebbe un ghostbuster.
MANIERO DI MANIERA – Fuoriuscita da un racconto di Edgar Allan Poe, Rossana Podestà si aggira con la veste bianca che sa di sudario in un’atmosfera notturna, tenuta in scacco come nei migliori Corman dal panico per un soprannaturale trasudante, eppure inafferrabile. I tuoni e i lampi, i drappi vaporosi, le scenografie lugubri e a tratti labirintiche appartengono a uno scavato armamentario del macabro, assecondato da una tecnica funzionale: con movimenti di camera lenti e avvolgenti – come tutto il ritmo della parte centrale del film – ci si sofferma su classiche porte cigolanti e finestre che si aprono da sole per effetto di qualche vento solforico. Lo sviluppo di queste premesse non propone significativi sussulti, puntando da un lato alla valorizzazione del clima impaurito nel maniero di maniera, dall’altro a consumare la propria svolta per lo più nel convulso finale, con un azzeccato flashback in bianco e nero che profila uno spaventoso personaggio, al quale forse non sarebbe rimasto insensibile il Fulci di Quella villa accanto al cimitero nel concepire il Dottor Jacob Freudstein. D’altronde, la donna con gli occhi che sanguinano, rinchiusa nell’armatura della vergine di Norimberga, è un’invenzione che, in qualche modo, può ricordare il simile espediente utilizzato sempre da Fulci in Paura nella città dei morti viventi (per quanto con trucchi così trasversali sia difficile ragionare di copyright d’ispirazione).
LA LUCCICANZA DI MARGHERITI – È proprio la Podestà a reggere le redini emotive della storia, da autentica vittima/eroina, ragazza che sapeva, o che sapeva troppo poco. Christopher Lee, veterano del genere, è tenuto in tutti i sensi nella penombra, funzionando comunque da carismatico comprimario, mentre George Rivière si fa carico dell’opportuna ambiguità. Ciò che vale la pena di apprezzare ulteriormente è la maestria, non priva d’ispirazione surreale, con cui Antonio Margheriti riesce a gestire le situazioni più splendidamente tenebrose o avventurose: qualche tratto rasenta persino il gore (non a caso decolorato), con scioccante modernità, ma soprattutto si assiste a incredibili scene di demiurgia degli elementi, sia il fuoco che l’acqua, quest’ultima protagonista in una memorabile sequenza con George Rivière che sembra uscito dall’Atalante.
Se si pensa all’ondata rosso sangue pre-shininghiana del film di fantascienza I criminali della galassia, di due anni dopo, s’intuisce come il regista italiano avesse dalla sua ben più dell’ordinario mestiere, aprendo brecce visionarie nella tranquilla routine di paura di genere. Peccato siano visioni troppo spesso relegate al vintage, semi-dimenticate: a volte un flashback non guasta.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
Scritto da Antonio Maiorino.