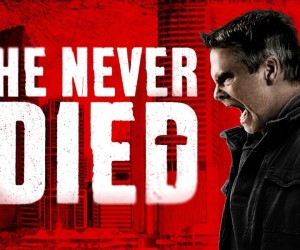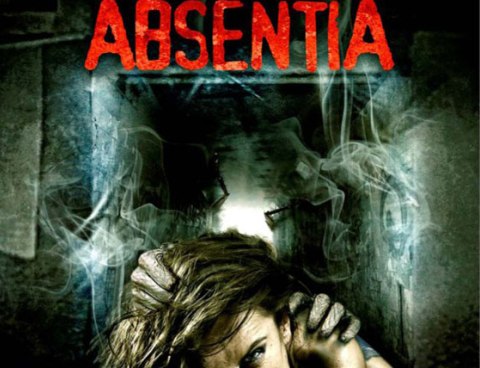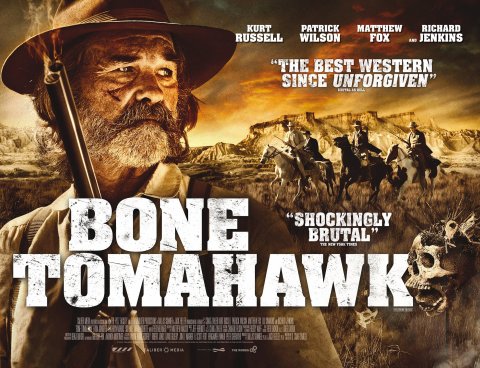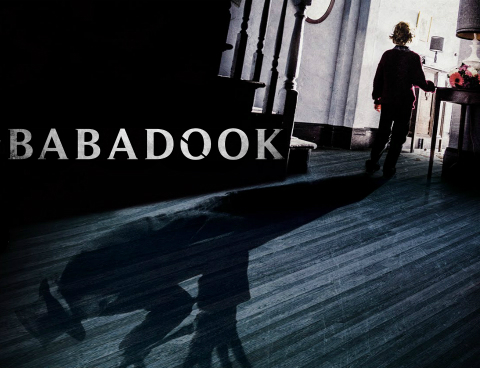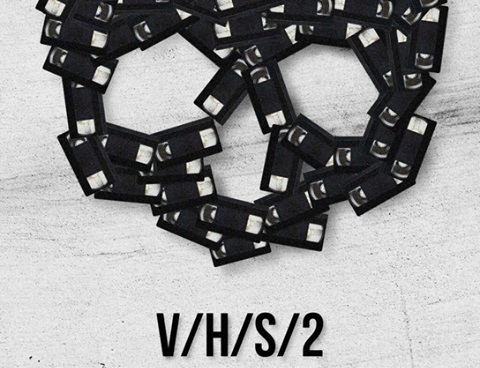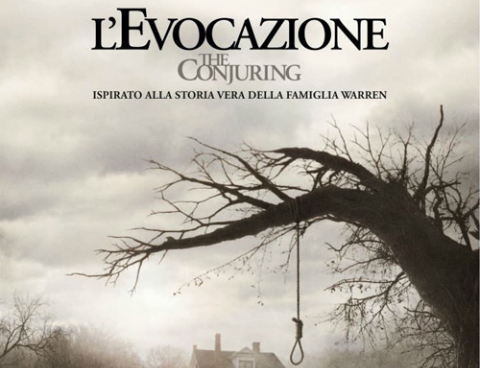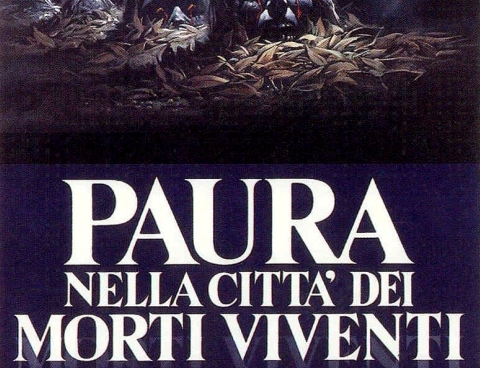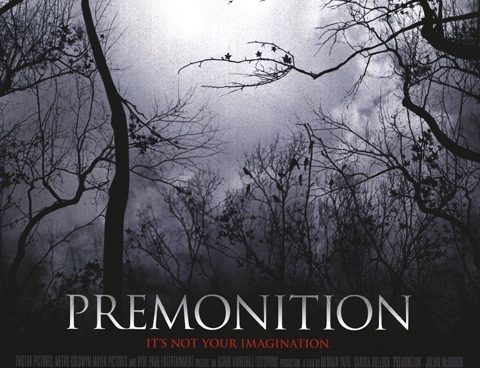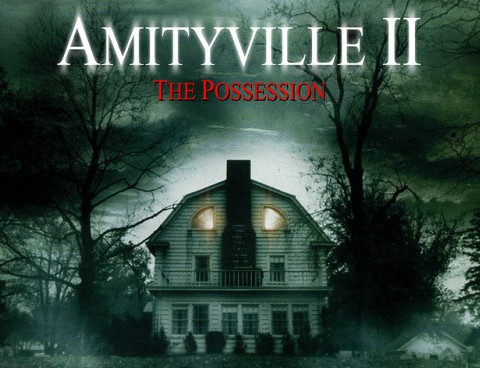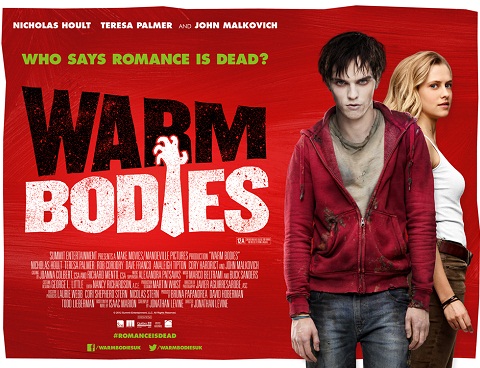Pet Sematary (2019): recensione
Corsi, ricorsi e parabole discendenti
Pet Sematary di Kevin Kölsch e Dennis Widmyer riesuma la storia concepita da Stephen King nell’omonimo romanzo del 1983 e già trapassata trasposta su schermo da Mary Lambert nel 1989 (Cimitero vivente). Un’operazione in linea con il tripudio imperante di remake e reboot, ma anche decisamente rischiosa: come la trama stessa insegna, riportare in vita i morti rischia di non portare al risultato voluto. Eppure, come capita anche per una certa serie ugualmente incentrata sul mantra what is dead may never die, il vero problema non è l’intento, ma il divario sconcertante tra una buona partenza e un tracollo ingiustificabile.

Cimitero vivente si difendeva egregiamente per essere stato realizzato con i mezzi dell’epoca: non era un capolavoro, ma, anche grazie alla sceneggiatura scritta dallo stesso King, riusciva a cogliere il senso più profondo (diciamo six feet under) del romanzo: non l’aspetto splatter (anche se non mancavano scene piuttosto gory), quanto il dramma intimo e lacerante della morte delle persone care. Pet Sematary riceve questo testimone e inizialmente pare farne buon uso, aggiornando ritmo ed effetti speciali alla sensibilità contemporanea.
Ritroviamo dunque Louis Creed (Jason Clarke) che si trasferisce ai margini della cittadina di Ludlow, nel Maine, per lavorare come medico scolastico e avere più tempo da dedicare alla moglie Rachel (Amy Seimetz) e ai figlioletti Ellie (menzione speciale per Jeté Laurence) e Gage (Hugo e Lucas Lavoie). L’unico vicino, l’anziano Jud Crandall (un ottimo John Lithgow), funge da Virgilio come nelle incarnazioni precedenti: è lui a consigliare di fare attenzione ai camion che sfrecciano sulla superstrada fra le due case, a spiegare a Ellie che il “pet sematary” dietro casa loro accoglie i resti degli animali domestici della zona da generazioni e infine a guidare Louis al vero cimitero, oltre la Palude del Piccolo Dio, in un terreno roccioso un tempo abitato dagli indiani Micmac. Quel luogo, va da sé, “ha un potere”, ovvero fa resuscitare i cari estinti, restituendoli però “cambiati“.

Nella prima parte Pet Sematary si destreggia bene sul doppio binario dell’attesa della tragedia annunciata e dei jump scare (talvolta ripetitivi, come il passaggio dei camion, ma in qualche caso realizzati con efficaci depistaggi). L’atmosfera è subito pervasa dalla presenza della morte: il film si apre con una processione funebre dei bambini della zona con inquietanti maschere da animali che evocano The Wicker Man e You’re Next, ma anche i conigli antropomorfi di Donnie Darko e Inland Empire e le versioni dark di Alice nel paese delle meraviglie. Fotografia e allestimento dei set esterni funzionano in modo ugualmente efficace, trasmettendo l’atmosfera ansiogena dei boschi anche grazie al contrappunto sonoro delle urla del Wendigo; il demone del folklore indiano non era contemplato nel film della Lambert, ma nel libro era un deus tutt’altro che ex machina, il vero burattinaio che manipolava i personaggi tirando i fili della sofferenza umana.
Sofferenza che nel remake è evidenziata, fra l’altro, dall’accento sul personaggio di Zelda, sorella di Rachel affetta da meningite spinale e morta molti anni prima: per quanto l’enfasi sulla mostrificazione del personaggio si spinga troppo oltre, verso The Grudge, l’esplorazione del senso di colpa di Rachel, tornata ai livelli del romanzo, acuisce la commistione fra vita e morte (fornendo fra l’altro un sanguinoso omaggio a Shining, contraltare dell’easter egg del cartello di Derry visibile poco prima).

E la morte non tarda ad arrivare nel presente, prima sul lettino di Louis (dispiace dirlo, ma il nuovo Victor Pascow sembra usato soltanto come “token black character”, in confronto all’immagine indelebile del predecessore) e poi insinuandosi in casa Creed, partendo dal gatto Church e arrivando a colpire la famiglia. Qui il remake prende una decisione coraggiosa e potenzialmente efficace, purtroppo però minata dal suo stesso apparato paratestuale: il trailer svela già che sarà la ragazzina novenne a rivestire il ruolo che nel libro e nel primo film era del fratellino di un paio d’anni. Senza l’autogol dello spoiler, la scelta avrebbe potuto portare una ventata d’aria marcescente fresca grazie all’identità più definita di Ellie, pre e postmortem.
In parte l’espediente funziona, soprattutto nella scena in cui Louis cerca di spazzolare la figliola rediviva e riceva la conferma tangibile dell’irreversibilità del cambiamento. Ma è qui che i nodi vengono letteralmente al pettine: anche la sceneggiatura comincia a decomporsi, proponendo dinamiche di un’ottusità pari a quella già mostrata da Louis nello scendere nella superflua cantina-da-film-horror-con-luce sfarfallante e precipitando poi verso un disastroso finale che vorrebbe distinguersi, ma fa soltanto colare a picco le premesse positive. Chiosa il tutto la versione annacquata di “Pet Sematary”, eseguita non dai Ramones, ma dagli insipidi Starcrawler, e triste metafora della parabola discendente del film.
| Alice C. | ||
| 5½ |