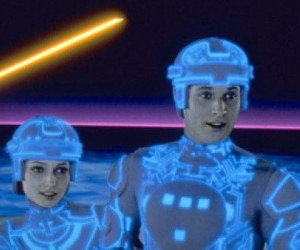Beasts of No Nation: la recensione
Il cuore di tenebra di Fukunaga si colora di rosso fra synth e piani sequenza

Tratto dal romanzo omonimo di Uzodinma Iweala (uscito da noi come Bestie senza una patria) e presentato a Venezia 72, Beasts of No Nation di Cary Joji Fukunaga è stato il primo lungometraggio di fiction originale prodotto da Netflix e distribuito contemporaneamente nelle sale e sulla piattaforma on demand (in Italia direttamente su quest’ultima).
Ambientato in un imprecisato Paese dell’Africa occidentale in preda alla guerra civile, il film racconta la vicenda di Agu, un bambino di nove anni che, scampato allo sterminio della sua famiglia per mano delle milizie governative, viene costretto ad arruolarsi in un esercito ribelle guidato da un leader carismatico quanto feroce.
Nel mettere in scena la sofferenza, l’orrore e la progressiva assuefazione alla violenza di un innocente, Beasts of No Nation si configura come un racconto di formazione alla morte, che diviene una costante nell’esistenza del protagonista, costretto alternativamente a esserne fautore o testimone sempre più impassibile. Al pari del capitano Willard in Apocalypse Now, il piccolo Agu – per la cui interpretazione l’esordiente Abraham Attah ha meritatamente vinto il premio Mastroianni – entra in contatto con il cuore di tenebra della propria specie, quella umana, composta appunto da folli bestie senza patria che rispondono soltanto all’istinto di uccidere perché è l’unica cosa che è stato loro insegnato a coltivare, in un viaggio fisico e mentale attraverso un inferno di stragi, droghe e stupri. A porsi come maestro di vita per i bambini-soldato, arrogandosi il diritto di abusarne in tutti i modi, è il crudele signore della guerra noto solo come il Comandante (ben interpretato da un agghiacciante Idris Elba), un concentrato di paternalismo, megalomania, stregoneria e perversione che, nell’inseguire vani quanto irriducibili sogni di gloria, sembra quasi una variante africana degli antieroi del cinema di Werner Herzog come Aguirre o Cobra Verde.
Già regista della prima stagione di True Detective, Cary Fukunaga dimostra più che discrete qualità di autore completo (oltre alla regia e alla sceneggiatura, qui firma anche l’ottima fotografia dai toni accesi e nitidi, che ritrae l’Africa nei suoi colori d’elezione), confezionando un film di notevole potenza visiva, con picchi di violenza esplicita, al limite dell’estetizzante, senza rinunciare a quei piani sequenza che sono ormai il suo marchio di fabbrica (ce n’è uno che resta particolarmente impresso, in cui la terra, il fango e tutto l’ambiente si tingono cammin facendo del rosso del sangue).
Alla lunga il meccanismo narrativo si raffredda in parte e, malgrado tanta cura dei dettagli estetici, di pari passo con la perdita di emozioni del protagonista si perde un po’ anche il coinvolgimento emotivo dello spettatore, con il sospetto che la forma prenda il sopravvento sulla sostanza, ma il regista riesce a non cedere alla retorica hollywoodiana e mantiene fino alla fine quell’ambiguità non consolatoria che sembra rifarsi a un’idea di blockbuster per adulti fine anni ’70-inizio anni ’80, a cui riportano anche le sonorità synth alla Tangerine Dream della partitura di Dan Romer.

| Davide V. | Edoardo P. | ||
| 6 1/2 | 7 1/2 |