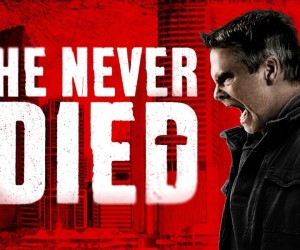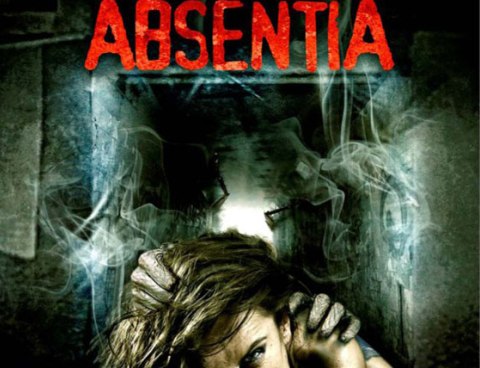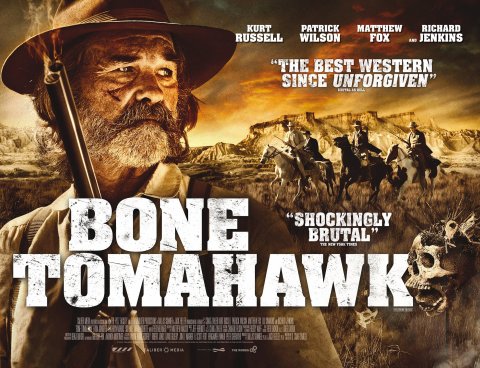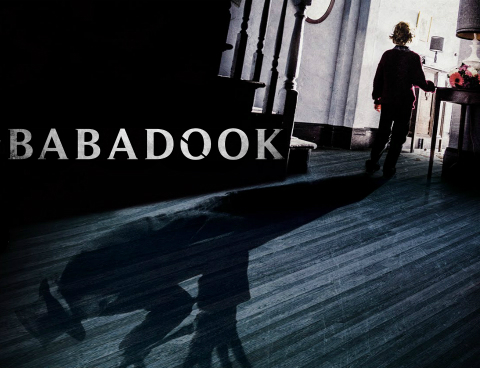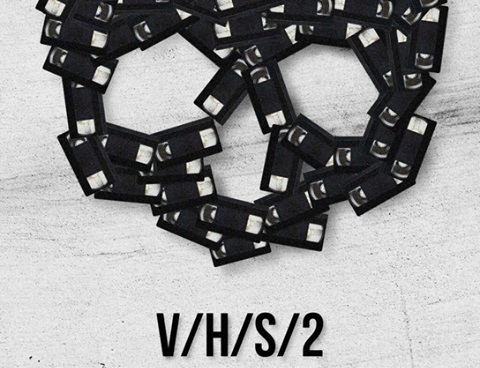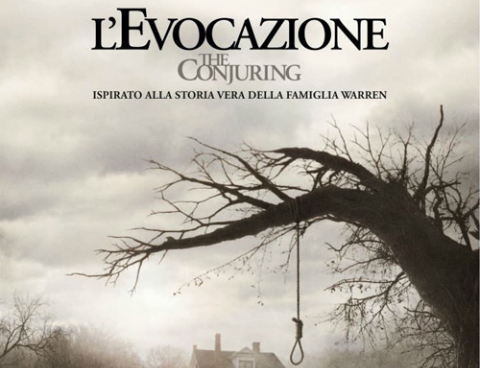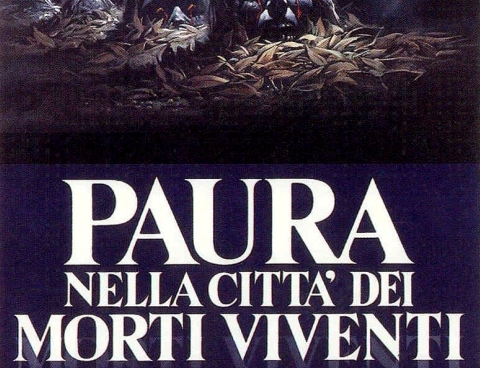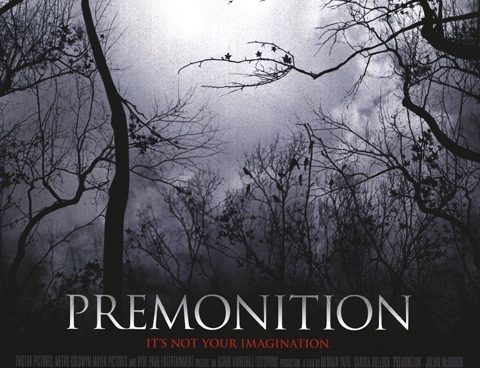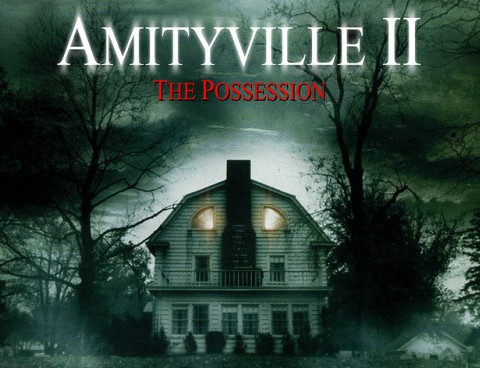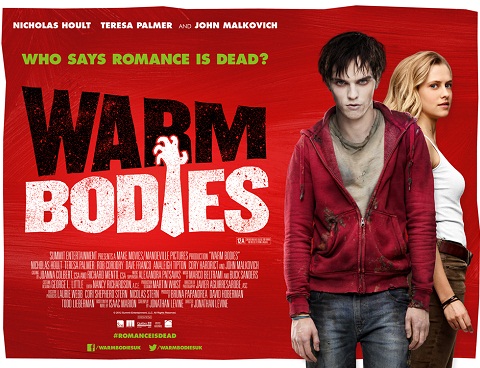Housebound: la recensione
Un raro equilibrio di humour e paura per un prodotto piacevolmente squilibrato

Tra gli highlights della scorsa stagione cinematografica dell’horror, Housebound di Gerard Johnstone, misconosciuto per molti, è risultato tra gli horror più elogiati dalla critica per il suo impeccabile profilo artigianale: vale a dire, sia pure senza (voler) avvicinare il capolavoro, il film consegue oggettivamente un mirabolante e quasi virtuosistico equilibrio di toni: una commedia horror domestica per distensive risate, ma anche un lambiccato rompicapo thriller per il piacere dello spettatore enigmista, dichiarate cadenze da filone “casa infestata” per scatenare brividi sottopelle agli amanti della vecchia scuola e lo slancio slasher degli sguardi assetati d’adrenalina e tensione real-time. Pizzicata dopo un bislacco tentativo di scassinare uno sportello bancomat, la scapestrata Kylie (Morgana O’ Reilly) è condannata agli arresti domiciliari per otto mesi. Prigionia doppia: la casa, abbandonata dalla giovane molto tempo prima, è quella d’infanzia, in cui la logorroica ed instabile genitrice (Rima Te Wiata) vive col proprio compagno. Forse, insinua la madre, c’è anche un altro inquilino: le porte scricchiolano e le cantine rumoreggiano come nelle classiche co-abitazioni coi fantasmi. Sarcastica e ostile, Kylie è costretta a ricredersi sulle fantasie della donna, scoraggiata da un condiscendente psicologo (Cameron Rhodes) ma sostenuta dal “vigilante” del suo braccialetto elettronico, Amos (Glen-Paul Waru), in versione ghostbuster dilettante.
BOUND… HOUSE-BOUND – Un cavatappi, uno xilofono, una grattugia: sono solo alcuni degli oggetti che diventano armi di offesa nella convulsa ultima parte del film, allorché si passa dal fioretto alla sciabola. In tutta la prima parte, infatti, il lavoro del cast tecnico è di fino e contribuisce a fare della casa un organismo che pulsa di vita propria: il design degli ambienti è ineccepibile, con stinte carte da parati, cianfrusaglie e chincaglierie che essudano oppressione, vecchiume, claustrofobia; la fotografia di Simon Riera, con angolazioni sbilenche ed ombre fonde, produce un effetto labirinto; lo score musicale di Mahuia Bridgman-Cooper, così serioso da essere uno scherzo, è brillante ed eclettico.
GRIND FINAL – All’ultimo terzo si arriva quando già le svolte e le contro-svolte, di tono più che di semplice intreccio, hanno leggermente spiazzato. Se la bambola pseudo-assassina, la statua di Gesù che caracolla, la porta che cigola e la casa dal passato oscuro sono cliché riciclati con efferata ironia, il neozelandese Johnstone, ammiccando ora più apertamente al connazionale Jackson e a Raimi, si affida a qualche sacchetto di sangue in più e all’insana alta tensione degli inseguimenti carnefice/vittima. Che tutto questo venga perseguito lasciando ancora balenare il controllo dei mezzi e il bilanciamento di humour e paura, è segno di equilibrio ed intelligenza. Se non fosse per questa coscienza del linguaggio di genere, non solo praticato ma osservato con divertito distacco, Housebound sarebbe l’ennesimo filmucolo da iscrivere al catasto dell’horror. Il buon senso, invece, fa sì che il film sia gustosamente assurdo.

| Antonio M. | ||
| 7 1/2 |
Scritto da Antonio Maiorino.