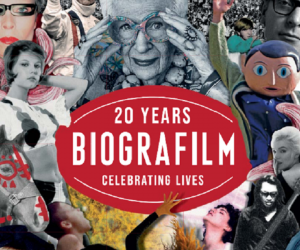Venezia 76 – Ema: recensione
Larraín dirige un film sanguigno che stordisce con la sua carica irrefrenabile
Ema di Pablo Larraín è dirompente, anarchico, lisergico. Dopo l’incursione hollywoodiana di Jackie, il regista cileno torna a un cinema latino e sanguigno con una pellicola che stordisce con la sua carica irrefrenabile e il suo tripudio di questioni esistenziali esperite visceralmente a suon di reggaeton. La protagonista eponima (Mariana Di Girolamo) è il cuore pulsante delle vicende, ma l’energia musicale, sessuale e affettiva che emana trova una cassa di risonanza perfetta nei personaggi ugualmente tormentati e umorali che la circondano.

Ema è spasmodica tanto nel ballo, quanto nella vita: la sua ricerca identitaria pare trovare l’espressione più completa nei sogni di maternità, ma il film ci rivela in apertura che qualcosa è andato storto con Polo, figlio adottivo “reso” dopo meno di un anno. L’allontanamento ha poi generato una crisi di coppia: Ema e il marito coreografo Gastón (Gael García Bernal) non fanno che rimbalzare dalle accuse reciproche a un sentimento talmente travolgente da riaffiorare con prepotenza di volta in volta (“es amor puro”, sintetizza García Bernal in conferenza stampa).
L’esplorazione sentimental-sessuale di Ema non si limita però al solo Gastón: fra l’avvocatessa sposata che (ri)trova la passione attraverso l’omoerotismo, il pompiere salvifico ma con l’anello al dito e le pulsioni primordiali del branco di compagne di ballo, la carica panerotica e poliamorosa pervade il film in un crescendo continuo, fino all’orgasmo (letterale e metaforico) del montaggio di tutte le scene di sesso con i vari personaggi, che consacrano Ema come ape regina del suo poliedrico alveare danzante.

Perché Ema è una forza della natura, un centro di gravità capace di attrarre tutti coloro che le stanno intorno e dar loro una direzione anche se lei stessa è perennemente irrisolta. In sé accentra l’essere donna, travolgente nella sua femminilità androgina fatta di tute da ginnastica e mullet biondo platino; l’essere ballerina contemporanea, attività che riempie ogni ambito della sua vita, dal lavoro come insegnante di ballo ai bambini alle prove quotidiane con il gruppo capitanato dal marito; e ovviamente l’essere madre (a ogni costo, con un piano ben più elaborato di quanto non appaia inizialmente).
Ema è anche un film estremamente radicato nella sua ambientazione: Valparaíso, con i graffiti e le lezioni di ballo al tramonto, completa la dimensione tangibile delle emozioni primigenie. Il fuoco interiore trova poi un correlativo oggettivo in quello utilizzato nelle coreografie, con percussioni tribali e ritmi atavici, e soprattutto nel lanciafiamme che Ema adotta come traduzione concreta della propria energia. Un modo per lasciare una traccia, come le tag sui muri: non arte in senso stretto, ma nomi, firme che legittimano i writer come autori della propria esistenza. Ed Ema, che pure subisce sulla propria pelle gli eventi di cui è protagonista, nel corso del film rivela una sorprendente capacità di plasmare la propria vita e quella degli altri. Il vortice di fiamme e musica approda a una dimensione forse scomoda, ma coerente con l’intento del regista di raccontare una concezione della famiglia e degli affetti declinabile in modi tutt’altro che convenzionali. Per Larraín non si tratta però di un’apertura recente, anche se la pellicola offre un’interessante esplorazione delle nuove generazioni: è piuttosto un ritorno alle origini, a un bisogno fondamentale di legami intrinseco alla natura umana. Ed Ema, pur nella sua contemporaneità sfacciata, sempre in bilico sul confine del trash, è un magnifico, potentissimo simbolo di un’umanità senza tempo e senza freni.
| Alice C. | Davide V. | ||
| 8 | 6½ |
Non siete a Venezia76? Il pass di Cinema Errante vi porta all’interno della Biennale Cinema 2019: restate con noi via Facebook, Twitter e Instagram per non perdere le recensioni e gli aggiornamenti in diretta dal Lido.