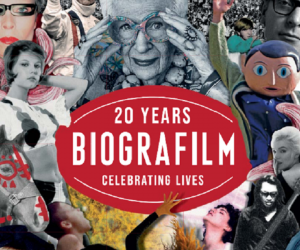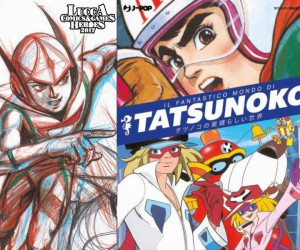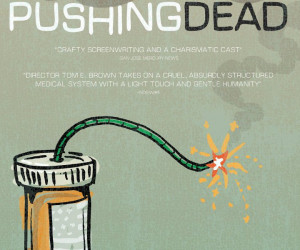FestivaldiBlogger Erranti,4 Settembre 2018
Venezia 75 – Charlie Says e The Sisters Brothers: recensione
Mary Harron con le ragazze di Charles Manson e il western di Jacques Audiard
Vi interessa la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ma non potete essere al Lido? Cinema Errante vi propone i Diari da Venezia 75, con i film visti in anteprima per voi.

Charlie Says di Mary Harron
Con Charlie Says la regista Mary Harron torna a indagare gli abissi senza fondo della mente umana. L’azzeccato titolo evidenzia subito l’oggetto del film: il modo in cui Charlie, ovvero Charles Manson, punta sulla propria parola per conquistare proseliti (paragonandosi non a caso a “ol’ JC”). Il fulcro non è tanto Manson in sé, quanto il lavaggio del cervello ai danni del suo entourage, in particolare di tre ragazze che mostrano un’identica fede nel “capofamiglia” nonostante i caratteri molto diversi. La pellicola si muove su due binari temporali: l’escalation che porta al sanguinoso 9 agosto 1969 (che per molti, secondo la citazione iniziale di Joan Didion, ha segnato la fine del mondo) si alterna alla dimensione del carcere femminile in cui le ragazze sconteranno l’ergastolo. Lo sguardo è quello di Karlene Faith (Merrit Weaver), scrittrice e docente di Women Studies presso il penitenziario, che tre anni dopo gli omicidi dell’Helter Skelter viene chiamata a tenere un corso per le tre giovani nella speranza di indurre in loro una presa di coscienza delle proprie azioni. La Faith, nomen omen, non si arrende di fronte all’imperitura, sconcertante devozione delle ragazze a “Charlie” e procede con la demistificazione della mitopoiesi mansoniana. Fra le tre fanciulle, la più permeabile è Leslie Van Houten, ribattezzata Lulu nella Family e interpretata da un’adattissima Hannah Murray; l’inconciliabilità tra l’aspetto innocente, l’altruismo innato e gli orrori di cui Lulu si è macchiata illustra efficacemente la portata del condizionamento mansoniano. Se l’accento sul fatto che le ragazze sono anche vittime, oltre che criminali, inserisce un tassello importante per la comprensione delle dinamiche della Manson Family, il film finisce però per scivolare parzialmente nella condiscendenza, eliminando qualsiasi arbitrio al di là di quello del leader. La figura dello stesso Manson risulta in qualche modo stemperata: Matt Smith convince in questo ruolo per lui inedito (eppure simile a Prince Philip in The Crown, come ha dichiarato l’attore in conferenza stampa), restituendo un Manson tormentato, volitivo e incontenibile, ma l’eccessiva insistenza sulla frustrazione musicale e sui deliri apocalittico-beatlesiani finisce quasi per deresponsabilizzare lo stesso mandante degli omicidi. La fotografia di Crille Forsberg, ricca di lens flare e toni quasi nostalgici, rafforza la sensazione che la pellicola, pur offrendo un’interessante prospettiva psicologica, non riesca a prendere una posizione netta, restando quindi lontana dall’incisività di American Psycho (e, presumibilmente, anche dall’atteso progetto tarantiniano su Manson, Once Upon a Time in Hollywood, in uscita a luglio 2019). (Alice Casarini)

The Sisters Brothers di Jacques Audiard
In un’edizione della Mostra così aperta al cinema di genere, non sorprende trovare in concorso un altro western oltre a quello dei Coen: si tratta di The Sisters Brothers, primo film girato in inglese da Jacques Audiard. Realizzato grazie all’acquisto dei diritti cinematografici del romanzo di Patrick DeWitt da parte dell’attore protagonista John C. Reilly, The Sisters Brothers è soprattutto il film di quest’ultimo, che infonde grande umanità al personaggio di Eli Sisters, il maggiore dei due fratelli del titolo, sicari al servizio di un boss al tempo della corsa all’oro in California: corpulento, goffo, a suo modo tenero e romantico, fondamentalmente buono anche se costretto a uccidere, Eli è Reilly al 100%, in una performance ad alto grado di empatia. Riesce anche a oscurare in parte un fuoriclasse come Joaquin Phoenix, leggermente sottotono nel ruolo del fratello minore Charlie, più intraprendente ma anche meno affidabile per il suo alcolismo violento. Ed è la bromance fra le due coppie di protagonisti, quella di sangue e quella di fatto – che si forma fra il riflessivo detective impersonato da un intenso Jake Gyllenhaal e il cercatore d’oro idealista con il volto di Riz Ahmed – l’ossatura portante di un film tutto al maschile, caratterizzato da toni picareschi e da un gradevole umorismo, che creano un’atmosfera di insolita armonia solo a tratti spezzata da inevitabili spargimenti di sangue. Le tematiche tipiche del cinema di Audiard, dove persone profondamente diverse per carattere e stile di vita tentano di rimettersi in gioco abbandonando l’individualismo e facendosi forza gli uni con gli altri, si adattano perfettamente all’ambientazione di frontiera, in cui il progresso dell’umanità sembra lottare con una primordiale propensione alla violenza, dando vita a un’avventura divertente e delicata, perfino commovente, memore del western maturo di Arthur Penn (Missouri su tutti) e con un pizzico delle schermaglie virili di Howard Hawks. (Davide Vivaldi)
Resta con noi via Newsletter, Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato su Cinema Errante.