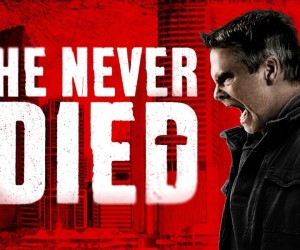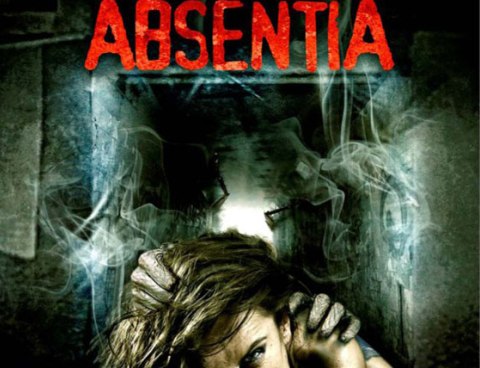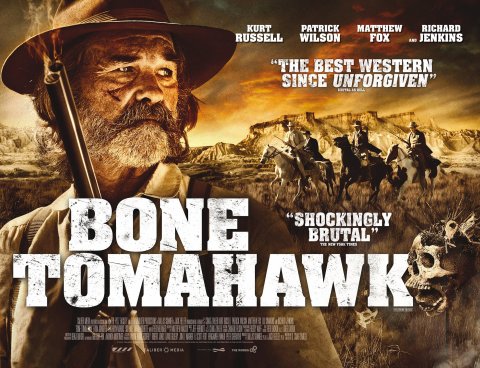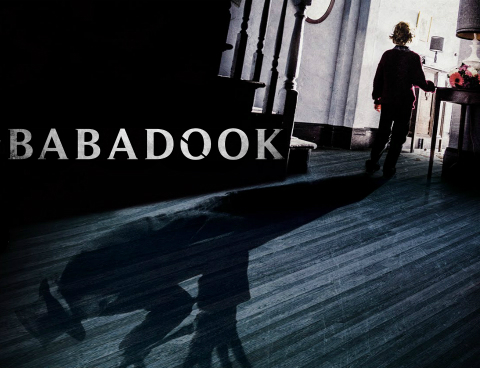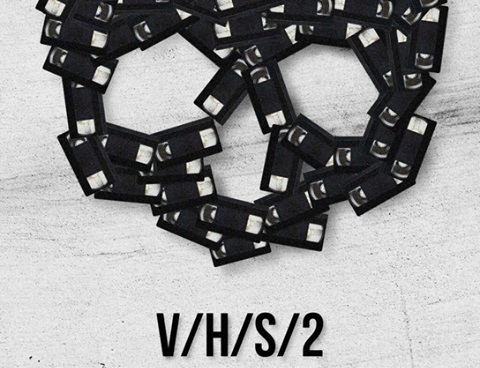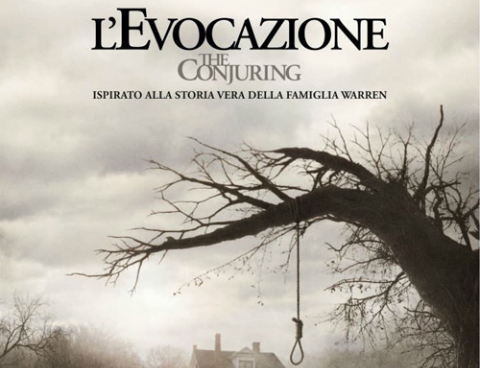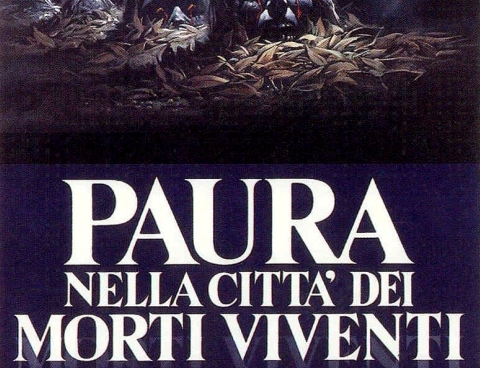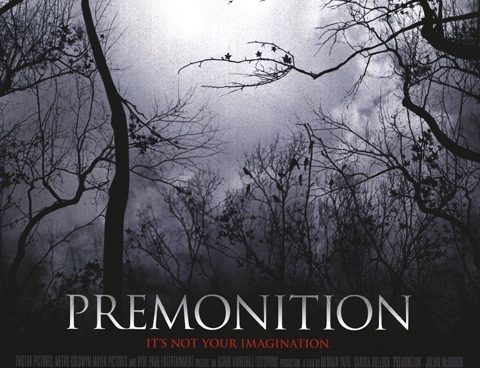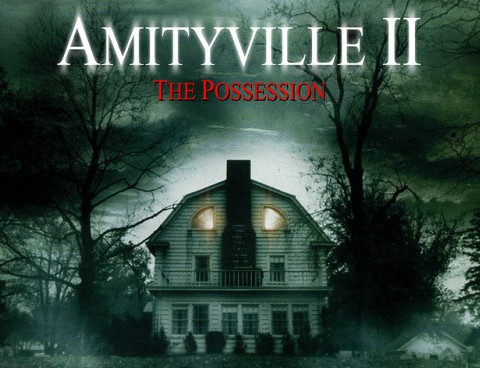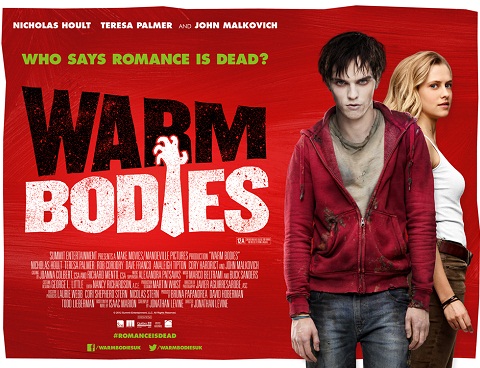The Conjuring 2 – Il caso Enfield: la recensione
Poco coraggio, tanta paura: la formula funziona. Così James Wan affina il suo horror mainstream

La paura fa novanta, ma anche settanta e ottanta, nell’ultimo scrigno degli orrori di James Wan, The Conjuring – Il caso Enfield. Che, per dirla tutta, da titolo originale fa The Conjuring 2: The Enfield Poltergeirst. Come spesso accade, il fenomeno paranormale della traduzione occulta due messaggi impliciti nel testo cinematografico: quel 2, che ci ricorda, se serve, che si tratta di un sequel, anzi, di un franchise, con tanto di spinoff passati (Annabelle) e venturi (sulla suora demoniaca, pare); e quel “poltergeist”, che non sembra tanto una concessione al lessico specialistico dei medium, quanto la spia di un immaginario costantemente affiorante anche nell’era del digitale.
Così, l’ultimo film del regista australiano, pur non eccellendo, è maledettamente efficace nel raccontare le sue maledizioni in un mix di suggestioni che partono dagli anni settanta (L’esorcista, The Amytiville Horror) per sublimarsi nel decennio successivo (Changeling, Poltergeist, Nightmare), rimanendo sotto il rigoroso controllo del diabolus ex machina James Wan, ormai riconoscibile in tutta una serie di stilemi, e non per questo prevedibile o carente d’inventiva: pianosequenza sgusciante e agili carrellate a percorrere gli spazi infestati; uso destabilizzante del secondo piano, buio e sfocato, che alberga i mostri; il climax che parte da nascondini e scricchiolii, ma non esita a squadernare anche precocemente i propri demoni, truccatissimi e orripilanti, come in quell’epoca dell’horror in cui a diavoli e affini lo spettatore amava credere sospendendo l’incredulità.
Col gusto dello stile Wan, The Conjuring – Il caso Enfield è dunque un saporito frullato d’invenzioni… non del tutto inventate, perché si tratta più che altro dell’affinamento del linguaggio mainstream, dell’horror da sala portato al più alto livello di artigianato (ma non di audacia); in aggiunta, riprende e dilata formula del suo stesso antecedente, compiacendosi di simulare tutta la sua artificiosità dietro la dichiarazione della storia vera, estratta dagli archivi dei coniugi Warren.
L’incipit è speculare a quello del primo film e le foto d’epoca dei titoli di coda, confuse con fotogrammi del film in effetto d’epoca, enfatizzano l’effetto ai confini della realtà, che mai e poi mai, per carità, oserebbe ricadere nell’effetto documentario, imprimendosi piuttosto le stigmate del melodramma amoroso (ma che bravi Vera Farmiga e Patrick Wilson), della scolastica colonna sonora (London Calling annuncia l’ambientazione londinese: che fantasia!), dell’armamentario ghostbusters.
Si tratta, in definitiva, di scelte conservative, ma che si conservano bene: non è questione di fifa a buon mercato, quanto di prendere atto che sul mercato del grande schermo prodotti di genere di questo tipo sono di manifattura eccellente, l’ideale per tanti fan. Divertiamoci, spaventiamoci, crediamoci – ma sia chiaro: l’horror-cinefilo del terzo millennio si rifornisce al 10% in sala, al 90% altrove. Il caso Enfield… è un caso.

| Antonio M. | Edoardo P. | ||
| 7 | 6 |
Scritto da Antonio Maiorino.