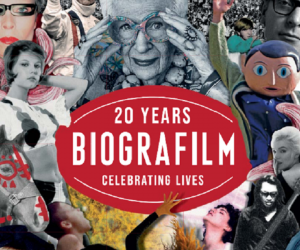Venezia 71. The Sound and the Fury: la recensione
Premiato con il Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2014, “in quanto tra gli autori più versatili e poliedrici della nuova scena americana”, James Franco porta a Venezia 71 il suo nuovo tentativo di riversare sul grande schermo un’opera letteraria. Questa volta le sue aspirazioni sono volte a The Sound and the Fury, tratto dall’omonimo romanzo del premio Nobel William Faulkner, capolavoro della letteratura americana, considerato una delle più grandi opere del XX secolo. Una impervia montagna che tratta temi come ingiustizia sociale, amore proibito e morte attraverso le debolezze e i fallimenti di una famiglia americana vicina ai tempi della Grande Depressione. Roba da far tremare i polsi. Ma non quelli di James Franco.
Affetto da un ego ciclopico, egli non si scoraggia, anzi la affronta baldanzoso. Divide il film in tre capitoli anziché quattro, uno per ogni fratello Compson. Riserva per se il primo, quello che descrive Benjy, bambino nel corpo di un trentatreenne. Unica figura positiva, col suo sguardo poetico ma attento, capisce tutto del microcosmo recintato in cui vive. Peccato che Franco nell’interpretarlo abbia invece uno sguardo vacuo e traduca il “puro suono” che “avrebbe potuto essere tutto il tempo, l’ingiustizia e il dolore” in un muggito. Un massacro che, incredibilmente, rende più accettabile la recitazione dei suoi ributtanti “fratelli”: il morboso Quentin e persino l’iracondo Jason, Scott Haze nuovamente diretto da Franco dopo Child of God e ancora senza registro emozionale, qui monotono nel suo furore. E non va certamente meglio nella regia. Troppo vanesio e narciso nelle proprie scelte, alla ricerca di un’impronta personale innovativa, una sorta di firma autoriale, Franco adotta uno stile fastoso. Nell’ansia da prestazione di voler dimostrare il suo indubbio talento, proprio non afferra che spesso poco è meglio di troppo. Allora ecco un’epifania di sterili orpelli che, evidentemente, gli piacciono tanto: slavina di note, voce off, continui flashback. Usa tecniche di ripresa differenti per ogni personaggio: ad esempio profonde il capitolo Benjy di soggettive, forse per rendere l’ottica del personaggio o forse perché c’è fin troppa verità nella sua stessa dichiarazione: “con la mia presenza aiuto il mio produttore a vendere meglio il film”. Il tutto viene infine mescolato da un serrato montaggio spezza-ritmo che, decelerando, rende la già difficile poetica di Faulkner abbastanza incomprensibile. Ne risulta un prodotto algido, piatto persino nell’acme del parossismo narrativo, lasciando così al tramortito spettatore la brutta sensazione che Franco sia tutto fumo e niente arrosto. Peccato.
![]()
Scritto da Vanessa Forte.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Davide V. | ||
| 4 |