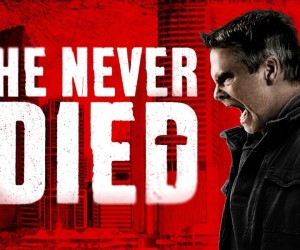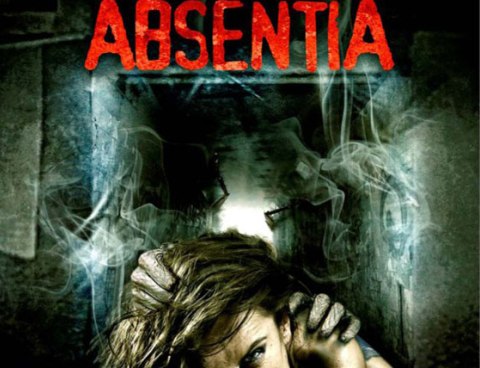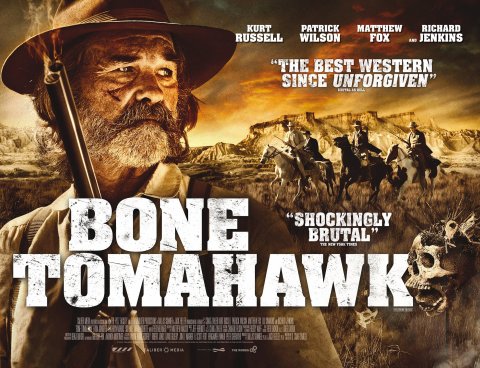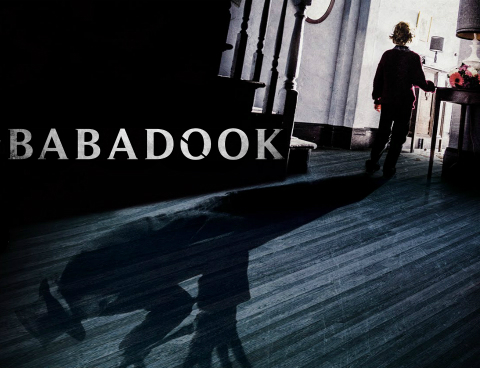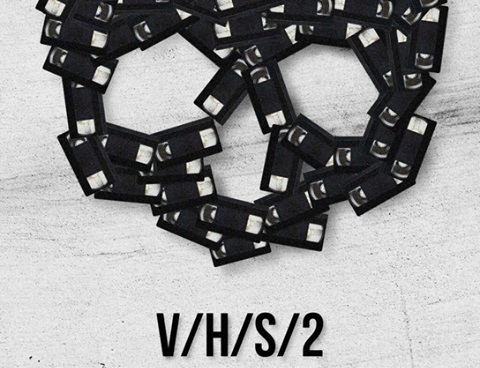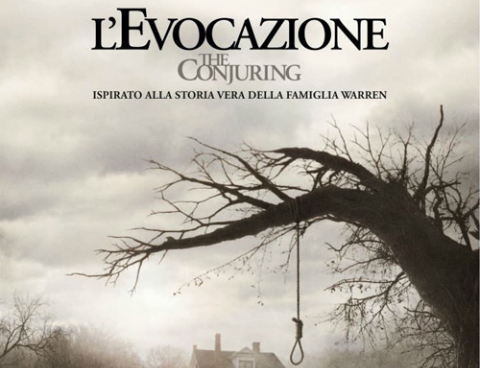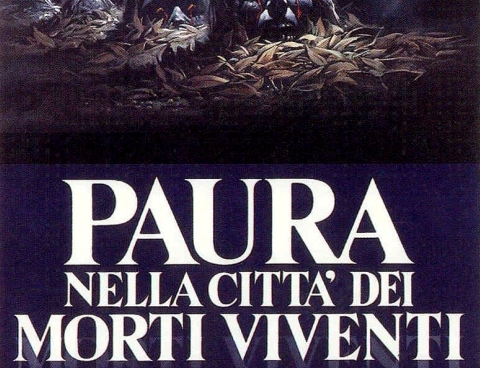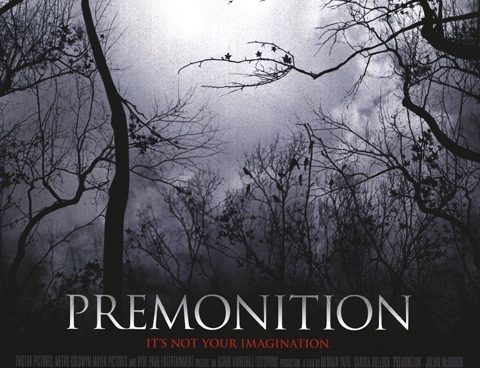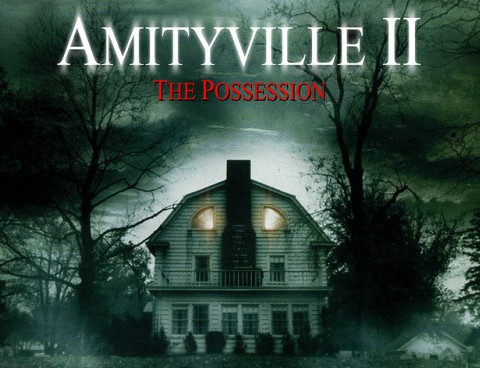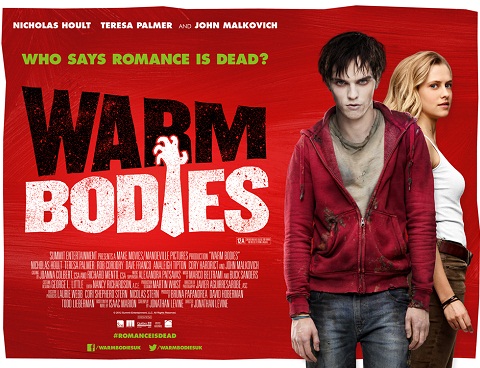Horror Ketchup – La vergine di Dunwich: la recensione
Visioni lovecraftiane in salsa psichedel-diabolica. Produce Corman
Non è sempre la somma che fa il totale. La vergine di Dunwich, infatti, aveva nel 1970 più d’una ragione per affermarsi come un horror d’effetto: la derivazione letteraria da un gigante come Lovecraft (il racconto L’orrore di Dunwich), la produzione di Roger Corman e la regia del suo scenografo di fiducia, quel Daniel Haller che già si era cimentato dietro la macchina da presa con La morte dall’occhio di cristallo (sempre tratto dall’opera letteraria del solitario della Providence). Lo stesso Corman, peraltro, aveva raccolto simili suggestioni, col riuscito La città dei mostri, pur miscelandole all’amato e irrinunciabile Edgar Allan Poe. L’esperimento di Haller rivela invece tutta la difficoltà a farsi carico del sentimento di gelo ineffabile della scrittura lovecraftiana, provando a riscattarsi sul piano delle immagini, disciolte in viraggi e psichedelie stregonesche.
Wilbur Whateley (Dean Stockwell) ha puntato il libro maledetto, il Necronomicon, appena giunto in una rara copia all’Università di Miskatonic col proprio carico di segreti dell’occulto. Ha messo gli occhi, altresì, sulla giovane bibliotecaria Nancy (Sandra Dee: sì, quella di Scandalo al sole), allieva del Dottor Armitage (Ed Begley). Mentre lo studioso è contrario al prestito del volume, la donna è come mesmerizzata da Wilbur: trascinata senza troppo scalciare, per seduzione e trame oscure, nella villa dell’uomo, passerà da qualche incubo tormentoso a pericolosi riti dal fine sinistro: far ritornare le antiche e oscure divinità del passato.
GRANDI ANTICHI E GRANDI MODERNI – Visti gli esigui incassi al botteghino, l’American International Productions rinunciò al proposito di sostituire Lovecraft a Poe per un nuovo ciclo dell’orrore. Semi-sepolto vivo dalla critica, che l’ha elegantemente obliato, La vergine di Dunwich di Daniel Haller parrebbe in effetti piuttosto datato nella veste, per quanto la medesima sorte sia condivisibile col grosso dei prodotti di genere di quegli anni. Pur decantando poco o nulla dalla matrice di Lovecraft, forse rivelatasi troppo scomoda, il film avrebbe più d’una ragione per farsi dissotterrare. Intanto, l’insistenza sui riti di Wilbur e sulla para-religione dei Grandi Antichi, con le invocazioni a Yog Sothoth, approfondiscono un elemento pagano che di lì a poco si sarebbe fatto apprezzare nel più fortunato (di critica, non di vicenda produttiva) The Wicker Man di Robin Hardy, tra i cult horror più apprezzati del ventesimo secolo. In seconda istanza, proprio quell’esuberanza pop dei viraggi fotografici, inseriti come flash demoniaci, insieme al gioco incrociato delle dissolvenze, a ben vedere rammenterebbe il recente Le streghe di Salem di Rob Zombie, non tanto per derivazione diretta, quanto per la comune tendenza (post-sessantottina in un caso, da rave-party degli anni duemila nell’altro) a trasformare la ritualità malefica in una sequela avvolgente e scioccante d’immagini drogate, lisergiche, ipnotiche.
IL VELENO E’ NELLA TESTA – Il culmine della pellicola, però, è la parte più usurata: uno strambo duello a suon di formule magiche tra Ed Begley e Dean Stockwell. Attorno non c’è comunque terra bruciata: l’arrivo dall’altra dimensione, poco prima, da parte della divinità oscura è resa con una serie d’impressionanti soggettive, come se il male spirasse dalla terra, piegando giunchi e ciuffi d’erba, sollevando una polvere mefistofelica dalle strade battute, obnubilando un cielo denso di presagio. In questo, si riecheggiano gli essenziali titoli di testa, a loro modo memorabili, con silhouettes nere su fondo blu, tra metamorfosi d’eleganza diabolica, come quella della collina che si anima e diventa una creatura gigante. L’ultimissimo fotogramma, poi, è un colpo di scena forse nemmeno troppo imprevedibile, ma apprezzabile per il colpo di coda in stile Rosemary’s Baby.
Visione bizzarra, più che propriamente avanguardistica, La vergine di Dunwich a ben vedere s’indebolisce proprio per la frigidità della Dee, remissiva nel personaggio e compassata nell’interpretazione, conservando nondimeno il fascino di un’esecuzione fantasiosa e scenografica.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
Scritto da Antonio Maiorino.