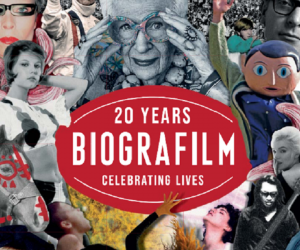Venezia 70. Child of God: la recensione
Ritratto di un sociopatico al di là del bene e del male
Child of God, film diretto da James Franco – ormai un habitué del Lido – e presentato in concorso a Venezia 70, è la storia del giovane Lester Ballard, un violento sociopatico che vive da eremita nelle foreste del Tennessee, e che cerca a modo suo di rientrare in contatto con quel mondo da cui si era emarginato. A modo suo, sottolineiamo.
Nonostante un soggetto di questo genere – tratto da un romanzo di Cormac McCarthy del 1973 e ispirato alle gesta del vero serial killer Ed Gein – Franco evita di trattare il protagonista alla stregua di un mostro, sottolineandone al contrario il lato umano, la voglia di comunicare, la totale incapacità di resistere all’istinto. Pur spingendosi oltre ogni limite di decenza e di buonsenso, e sconfinando nella perversione sessuale di ogni tipo e nel crimine più efferato, Lester resta un umano de-evoluto allo stato animale, un personaggio al di là del bene e del male con il quale il regista vuole farci entrare in sintonia, evitando ogni giudizio morale e girando con una precisione scientifica degna di un documentarista. Inoltre, assecondando la visione grigia e pessimistica della società tipica dello scrittore, Franco sottolinea il fatto che il protagonista non è che uno dei tanti a commettere atrocità, mostrandoci un mondo in cui la violenza è comunque diffusa e quasi normalizzata.
Aiutato dalla grande prova recitativa del virtuosistico Scott Haze – che da buon seguace del metodo Stanislavskij è vissuto in isolamento per tre mesi per immedesimarsi meglio con il personaggio – e del bravo caratterista Tim Blake Nelson nella parte dello sceriffo, e riservando a sé stesso il ruolo minore del capo dei vigilanti, Franco si conferma valido anche dietro la macchina da presa, soprattutto nello spezzare la violenza e la desolazione con la giusta dose di umorismo sarcastico (memorabile la sequenza del tiro a segno) e nel riprodurre la wilderness dell’America rurale sulle piacevoli note, ispirate alle sonorità folk tradizionali, del giovane Aaron Embry. Peccato soltanto che alcune sequenze appaiano un po’ tirate per le lunghe, rallentando il ritmo del film, e che a volte si indugi troppo su dettagli efferati o ripugnanti (c’è anche una scena di defecazione), con il sospetto di voler a tutti i costi scioccare lo spettatore.
Il talento è indubbio. Qualche minuto in meno, un pizzico di pudore in più, e sarebbe stato un buon film.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Giacomo B. | ||
| 7 |