La madre: la recensione
La madre di Andres Muschietti. «Le mamme e i papà ci provano a fare le cose bene, ma a volte fanno un gran macello» dice Jeffrey alla figlioletta Victoria (Megan Charpentier). E questo papà un macello l’ha fatto per davvero, avendo appena ucciso la moglie e due colleghi d’ufficio. Effetto Wall Street, come nel ’29: colpa della crisi, declama la radio. Di nervi, anche. Ora Jeffrey è in un cottage nei boschi innevati, ripresi da una gelida fotografia azzurrina, col rosso del sangue momentaneamente congelato nell’ellissi del prologo. È filato via con le bambine, e ha una pistola. Il macello continua? Sì, ma non a danno delle piccole. Una misteriosa presenza – «non tocca per terra», dice Victoria, ma il padre non l’ascolta – assale l’infausto genitore. Cinque anni dopo, le bambine vengono ritrovate: la minore, Lilly (Isabelle Nélisse) cammina a quattro zampe e mangia insetti, gibbuta e rampicante come un Gremlin; Victoria conserva un barlume di civiltà. Entrambe sono affidate allo zio Lucas (Nikolaj Coster-Waldau, il Jaime Lannister di Game of Thrones, che qui interpreta anche Jeffrey in versione sbarbata) ed alla convivente Annabel (Jessica Chastain, rockettara tatuata in versione dark). La coppietta cerca di riabituarle alla civiltà, ma la creatura che le aveva salvate cinque anni prima e custodite aggressivamente – “madre” – non sembra caldeggiare il progetto.
Esordisce dunque col fantasma della crisi, questa ghost story classicissima di Andres Muschietti, che sviluppa il suo stesso cortometraggio in lingua spagnola del 2008 avvalendosi della produzione di Guillermo del Toro. Stretto nella morsa tra topoi del genere e luoghi comuni del sub-filone, con in mano uno script né irresistibile né innovativo, Muschietti squaderna quantomeno un piglio volitivo nella regia: una marea di carrellate in avanti ed indietro, che sembrano veicolare il perpetuo incombere di una minaccia; diffusi magheggi con la penombra in interni piuttosto scuri; una lentezza avvolgente ed ipnotica, ma mai davvero noiosa.
È forse questa domesticità impossibile, con le creaturine che non si lasciano addomesticare facilmente, a costituire l’umore più suggestivo nell’atmosfera del film. L’interessante regia è persino a tratti polanskiana (L’inquilino del terzo piano? La nona porta?), in termini stretti di tragitti della macchina da presa negli ambienti, con inquietudini che strisciano nei corridoi e stipiti, balaustre e scale che sembrano costipare il campo, farne una gabbia d’impossibile evasione psicologica. Il tema della visione ostacolata, anzi, percorre sottotraccia l’intera vicenda, con almeno due sequenze di prestidigitazione nera dello sguardo: nelle battute iniziali, quella in cui il padre sfila gli occhiali a Victoria prima di spararle, e la bambina, miope, vede – o meglio, non vede – la figura sfocata del “mostro”; poco più avanti, quella in cui Lily gioca in camera contendendo una coperta a una figura fuori campo, effetto conseguito riprendendo con una sorta di prospettiva bifocale, di spigolo, il corridoio che si allunga a sinistra e la stanzetta con la bimba semi-aperta sulla destra. E non sono episodi isolati: apparizioni nello specchio, luci intermittenti, figure mostruose che sgusciano dietro Annabel, parzialmente occluse dalla sagoma della donna, mentre la macchina da presa stringe su di lei, si collocano sullo stesso binario di visione deragliata, di fantasmatica semi-visibilità.
La strategia della suspense, quindi, diventa letteralmente strategia di sospensione visiva: spesso la macchina da presa segue lo sguardo delle bambine che riescono a vedere la “madre”, mentre gli adulti – e gli spettatori – non ne percepiscono la presenza ottica. Che sia Jessica Chastain, poi, a prendere le redini del dramma e ad avvertire per prima dopo le bimbe la presenza della “madre”, è coerente con questa castrazione delle pupille, in una storia che provede per e-virate, piuttosto che per virate: all’inizio scompare il padre, poi viene ferito lo zio, e restano a giocarsela le donne, uniche a vedere, uniche a sentire. Se, come dice a un certo punto un’archivista – guarda un po’, donna – «un fantasma è un’emozione», e quell’emozione in genere deriva da un “torto”, la sensazione è che l’uccisione della madre – quella vera, non mostrata dalla macchina da presa – sia un escamotage narrativo per rendere più impattante uno sviluppo teso al riscatto della maternità per vie occulte. La profonda umanità del mostro, una madre che ha trasfigurato in aggressività ectoplasmatica il torto di non aver potuto accudire in vita la propria creatura, è la riprova di questa femminilità ferita nel proprio impulso ancestrale di essere, appunto, mama.
Dare sfogo, anche visivo, a questa tensione, dopo aver così a lungo celato la protagonista soprannaturale, era un problema non da poco: in sintesi, la questione dello “scioglimento”. Ebbene, l’esordiente Muschietti mostra effettivamente di perdere qualcosa in tenuta diegetica e stilistica nell’ultima mezz’ora. Scricchiolii alla The Grudge, e omologhi giapponesi, e vedo/non-vedo alla The Others, sono sempre abbordabili da gestire: portare tutto a felice conclusione è più difficile. Così, nell’ultima parte si assiste forse ad un procedere più rapsodico e scollato, come di eventi che precipitano troppo velocemente. E la figura della madre si vede persino troppo, dopo tanto buio: per scoprire che in fondo è una figura già vista. Filiforme e gracchiante come in Rec di Balaguerò e Plaza, innanzitutto: clamorosamente citato nella scena in cui l’essere si muove al buio, ma viene occasionalmente illuminato dal flash della macchina fotografica (in Rec 2 c’è la sequenza omologa della camera ad infrarossi che riprende cose invisibili alla luce). Ulteriore somiglianza è con l’horror francese Livide (2011) di Alexandre Bustillo e Julien Maury, altra vicenda di istinto materno morboso, che con La madre condivide un’inattesa svolta gotica nel finale: che la figura della genitrice sia volante (non lo era nel cortometraggio) è sintomatico di un finale dal sorprendente twist da favola orrorifica, forse memore anche de Il labirinto del fauno diretto proprio dal produttore Guillermo del Toro. Sarà una similitudine casuale, ma intanto sia in Livide che in La madre compaiono le falene e gli interni labirintici, mentre tutto trascina a un ritorno alla natura selvaggia, a un “fuori” selvatico.
La madre di Andres Muschietti è dunque un horror rosa shocking che annerisce in nero gotico, lasciando sfumare nell’ultima parte una certa civile linearità, ma facendosi apprezzare per ampi tratti per coerenza di sguardo e suspense da ghost story, sia pure in formato “a volte ritornano”.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Alice C. | Davide V. | Edoardo P. | Giusy P. | Irina M. | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Scritto da Antonio Maiorino.















































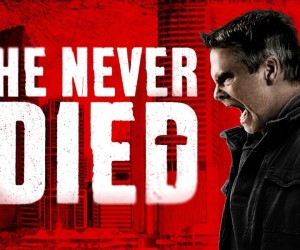






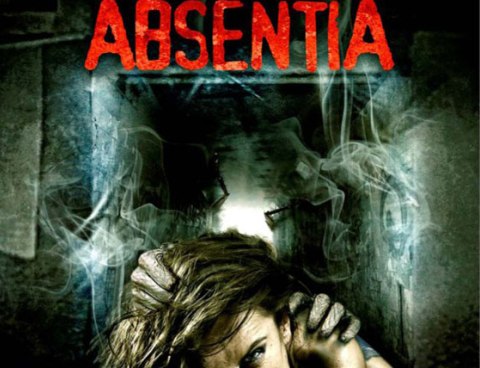
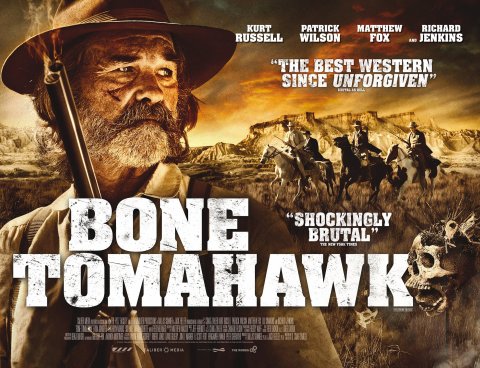





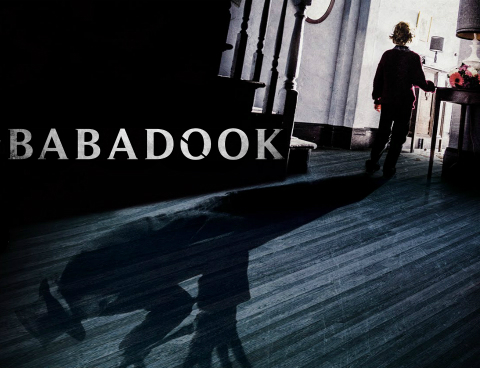
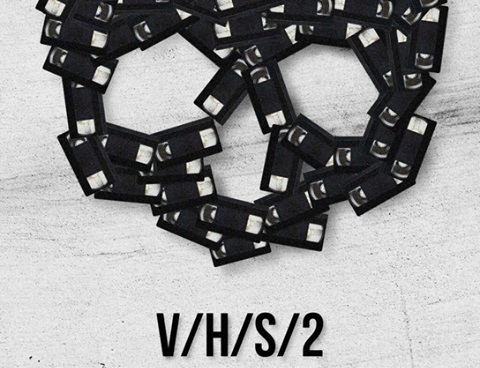































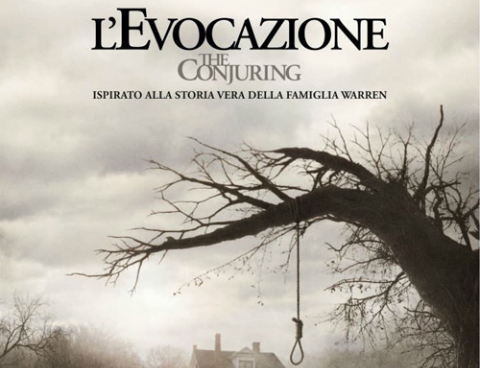
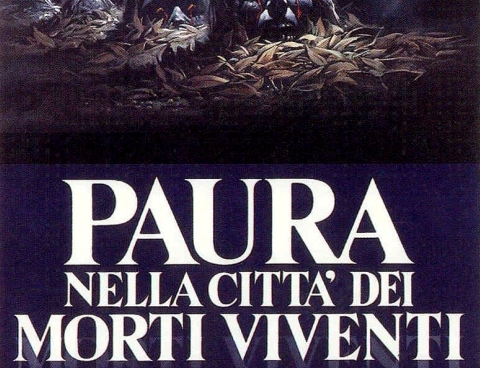







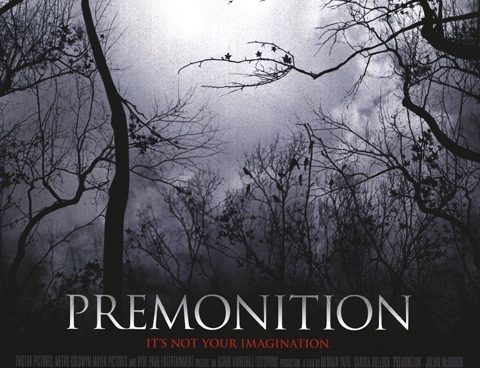


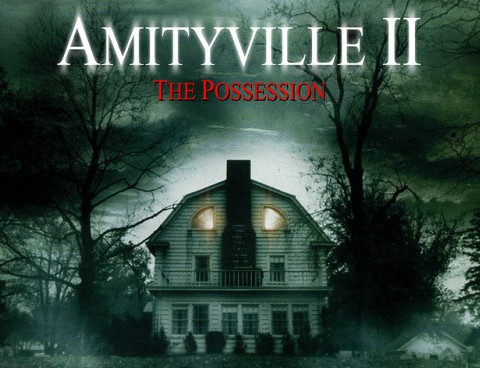




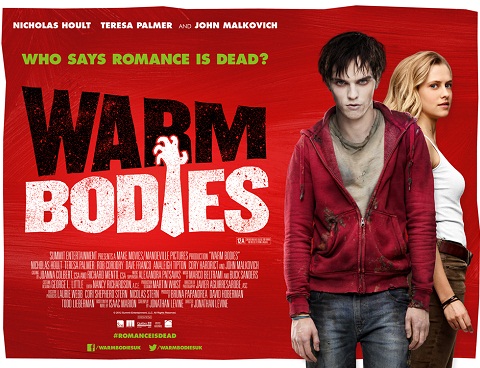






Anche io concordo con la bella analisi, e con l’ottima recensione anche se, personalmente, trovo che comunque anche nella parte finale si sia riusciti a trovare un onesto compromesso tra tensione e convenzionalità.
Non ho ancora visto Sinister 🙁 mi ispira molto
Vero, in questo senso il recente “Sinister” era stato invece esemplare nel compromesso tra “fisicità dell’apparizione” e moderazione nel far vedere “il mostro”. “La madre” invece abbraccia una presunta spettacolarità insistendo su questa creatura disarticolata e, nel finale, iper-esposta. Ecco perché sospende la suspense e diventa, dopo tutt’altro svolgimento, una strana sorta di gothic horror 🙂
Concordo sulla valutazione e sull’analisi; peccato davvero che Madre si veda così tanto, continuava a ricordarmi l’Ecce Homo sfigurato, togliendo tensione 🙂