La Bottega dei Suicidi: la recensione
Patrice Leconte vuole imitare Tim Burton, ma con La Bottega dei Suicidi ci riesce solo a metà. Echi burtoniani, atmosfere alla Nightmare before Christmas, gusto per il macabro stile Famiglia Addams e una buona dose di ironia sono gli ingredienti a cui Patrice Leconte si è ispirato per la ricetta del suo primo film animato, che però non sembra aver raggiunto il risultato sperato. La Bottega dei Suicidi pare aver perso la tonalità scura e tenebrosa, il sapore più amaro e al contempo più corrosivo del best seller di Jean Teulé da cui è tratto.
Al centro del libro e del film la famiglia Tuvache, che da generazioni gestisce una bottega di armamentari utili al suicidio. Gli affari vanno a gonfie vele, persino i piccioni si suicidano in questa città senza nome, ma a tutti è fatto divieto di uccidersi in pubblico. A mettere a rischio il successo della ditta Tuvache è la nascita di Alan, il terzogenito dopo la triste e insicura Marilyn e l’apatico e inquietante Vincent. Alan è diverso dai suoi fratelli, lui sorride alla vita, è entusiasta e sprizza allegria da tutti i pori. Un’allegria contagiosa che potrebbe colpire anche i preziosi clienti della bottega e dissuaderli dai loro propositi di morte.
Ci troviamo in un non-tempo e in un non-spazio e Leconte motiva l’atemporalità del suo film col fatto che sarebbe stato troppo semplice dire che è la società moderna a spingere al suicidio. Ci sembra, però, che sia altrettanto semplicistico ridurre tutto allo slogan che la vita è bella e che per questo valga la pena viverla fino in fondo. “La vita non è sempre bella, ma è sempre meglio della morte”, ammette Leconte. Eppure perché debba essere migliore della morte, questo il film non ce lo dice, e in fondo nessuno può spiegarlo. Forse è proprio la profondità di un tema così grande, che rischia di essere sviluppato in maniera didascalica, il problema di un film che vuole essere un inno alla vita e fallisce in quanto a incisività e potenza. Questo, in gran parte, per colpa di una sceneggiatura quasi senza evoluzione, con pochi avvenimenti, per lo più insufficienti, e personaggi che restano delle silhouette di cartone, piatte e monotone.
I personaggi cambiano senza un reale arco di trasformazione, ma solo perché Alan ha deciso che la sua allegria debba servire a qualcosa. Ed è proprio il personaggio di Alan il meno riuscito, il più uniforme e sempre uguale a se stesso. Ciò che lo spinge a mandare all’aria gli affari di famiglia e a salvare decine di vite umane non è il gusto di fare dispetto a papà Mishima Tuvache, ma è la sua allegria che non tollera l’eccessiva serietà e la tristezza degli adulti. È un amore vago e indefinito per l’umanità e per la vita a spingerlo. Un amore che un bambino reale vive senza la consapevolezza di Alan, ma attraverso un’innata meraviglia, un incanto immotivato e un desiderio di scoperta del mondo, che gli fa desiderare di esplorarlo e non di abbandonarlo con una dipartita.
Stupisce che un regista che ha trattato il tema del suicidio con lirismo e leggerezza ne La ragazza sul ponte, abbia fatto, è proprio il caso di dirlo, un tuffo nel vuoto con un film che non coinvolge e che non incide. L’ironia, la presa in giro del suicidio, questo tentativo di esorcizzare la morte sono gli elementi più interessanti del film, che lo avvicinano al modello a cui Patrice Leconte dice di essersi ispirato, e cioè all’universo macabro e favoloso di Tim Burton. A quel modo di rendere normale la mostruosità, di condurre l’orrido all’eccesso (si pensi alla lametta usata e arrugginita, che se non taglia le vene almeno ti fa prendere il tetano), al sapore dark di certe atmosfere e di alcuni personaggi, soprattutto Vincent, il fratello brutto e funereo che disegna incubi mostruosi e neri come quelli del suo omonimo di burtoniana memoria.
Scritto da Vera Santillo.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Edoardo P. | ||
| 5 |

































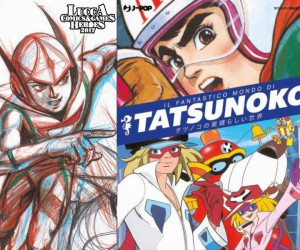








































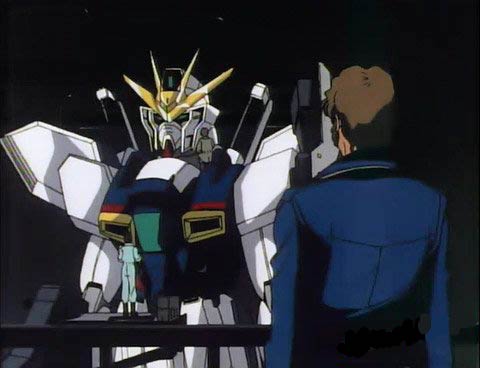




































Già… è la riprova che non basta un’ottima idea alle spalle(in questo caso quella originaria di Teulé) per fare un buon film 🙁
Peccato, la premessa era decisamente intrigante 🙁