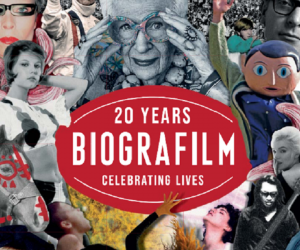Venezia 71. Nobi: la recensione
Ormai un habitué del Lido, Shinya Tsukamoto partecipa in concorso a Venezia 71 con Nobi, nuova trasposizione del romanzo omonimo di Ooka Shohei, già portato sul grande schermo da Kon Ichikawa nel classico Fuochi nella pianura (1959). Per la prima volta alle prese con un film di guerra, il maestro giapponese del cyberpunk non rinuncia alla sua idea di cinema disturbante sia sul piano visivo che su quello sonoro, riproponendo in un’ambientazione bellica i temi più frequenti della sua filmografia: la discesa nella follia, il disfacimento della carne e della mente, la trasformazione dell’uomo in un’altra forma di vita di cronenberghiana memoria, anche se qui solo in senso figurato, in una sovrapposizione continua di realtà e allucinazione.
La vicenda di Tamura, un soldato giapponese allo sbando (impersonato dallo stesso Shinya Tsukamoto), che cerca di sopravvivere in un’isola del Pacifico dopo lo sterminio del suo plotone, abbandonandosi progressivamente alle decisioni più estreme, rimanda infatti alla delirante progressione narrativa alla base della sua opera più famosa, Tetsuo (1989); anche se in questo caso non avviene alcuna mutazione fisica, anche qui il protagonista è costretto a rinunciare progressivamente alla propria umanità, superando uno dopo l’altro tutti gli ostacoli che lo separano dal diventare un vero e proprio mostro e perseguire fino in fondo il proprio obiettivo, ovvero la sopravvivenza. Sempre più malato, in preda alla tubercolosi e alla fame, vittima di continue allucinazioni e alla costante ricerca di cibo che, in questo contesto, diventa un’ossessione assumendo connotati orrorifici, Tamura paga a sue spese l’altissimo prezzo di una guerra del tutto priva di senso. Una guerra che, pur essendo chiaramente la Seconda Guerra Mondiale, potrebbe rappresentare tutti i conflitti, ugualmente terribili e disumanizzanti, in linea con il messaggio antimilitarista alla base della fonte letteraria e del film stesso.
Per una precisa scelta registica, il nemico non si vede mai in scena, se non attraverso lo sguardo delirante del protagonista (quindi sotto diverse sembianze), ma in compenso si vedono e si sentono gli effetti devastanti delle mitragliatrici, che falciano via le deboli vite dei soldati facendo letteralmente a pezzi i loro già fragili corpi, con un tripudio di sangue e mutilazioni in sintonia con un’estetica decisamente splatter. Lo stridio feroce dei proiettili, le urla, le risate isteriche, il latrato impazzito dei cani, l’inquadratura tremante e fosca: tutto è finalizzato, senza mezzi termini, a coinvolgere lo spettatore nella fuga dall’inferno del protagonista. Un inferno che ha il colore verde della natura incontaminata, e macchiata di tanto in tanto dal rosso del fuoco e del sangue.
Un film senza dubbio di forte impatto, ma alla lunga un po’ ripetitivo nonostante la breve durata, che in fondo non aggiunge molto né alla filmografia del regista nipponico, né rispetto alla precedente trasposizione del romanzo ad opera di Ichikawa, più sobria ma, tutto sommato, più efficace.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.